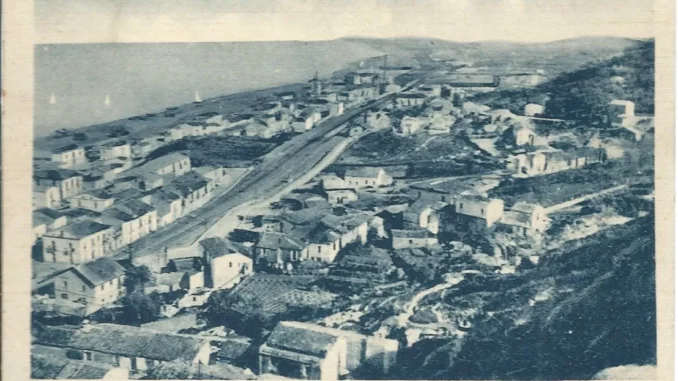
di MAURO SANTORO
Cariati e la sua Marina che si specchiano nel mare Jonio, con la vicina Terravecchia, da tempi immemorabili costituiscono il lembo di territorio meridionale della sibaritide e, oggi, ultimi paesi della provincia di Cosenza, confinano con l’attuale provincia di Crotone. Il fiume Nicà, con le sue anse e l’ampio delta che sfocia sull’arenile cariatese, rappresentava nei secoli luminosi della Magna Grecia il naturale confine tra la pitagorica Kroton e l’opulenta e ricca Sybaris.
Una cittadina, quella cariatese, con una sede vescovile di antiche origini, che dopo l’unità d’Italia vedeva incrementare la popolazione sin dal censimento del 1861 che aveva rilevato, in quella occasione, 2246 abitanti.
Nel 1901 i residenti erano 3086, questo emergeva dai dati censuari registrati negli annali degli archivi dell’Istituto nazionale di statistica, e poi ancora nel 1921 i cittadini erano 3374. Negli anni successivi alla prima guerra mondiale, pur con tutte le perdite di vite umane che il conflitto provocò, la popolazione di Cariati continuava ad aumentare fino a raggiungere le 4117 unità nel censimento del 1931. Evidentemente, quell’incremento era dovuto anche ai trasferimenti d’interi nuclei familiari provenienti dai paesi collinari e montani della Sila Greca che si riversavano nella marina alla ricerca di migliori condizioni di vita per la presenza di un’efficiente strada litoranea (attuale statale 106 ionica), di una stazione ferroviaria e di prospettive economiche facilitate da numerose attività commerciali e manifatturiere. Terravecchia, data la vicinanza a Cariati – appena otto chilometri di strada -, probabilmente contribuì in minima parte a quell’incremento poiché nel 1911 il paese aveva 1336 residenti e 24 in più del successivo censimento del 1921.
Nelle rilevazioni del 1936, l’ISTAT contava una popolazione residente di 4074 unità per Cariati e 1327 abitanti per Terravecchia.
Più specificamente, riguardo alla cittadina cariatese, la popolazione era così suddivisa: nel paese antico risiedevano 1854 cittadini, di questi 246 vivevano in case sparse; la marina censiva 2220 unità – ripartiti: in 1887 nell’abitato e 343 nelle case sparse delle campagne.
La popolazione effettivamente presente, invece, era costituita da 3961 unità – 1848 maschi, 2113 femmine -; di questi 3830 erano cittadini abituali, 131 occasionali.
Erano assenti 244 cittadini; di questi 208 erano in altri comuni, 36 nelle colonie dell’Africa orientale. La sintesi del censimento del 1936 fece emergere che Cariati aveva 4074 residenti – 1974 maschi e 2100 femmine -; sul totale, 3485 abitavano nel centro urbano e 589 nelle case sparse.
Più dettagliatamente, la classificazione di statistica rispetto alle categorie di attività economica, registrava che dei 3961 cittadini presenti: 997 erano occupati nel settore agricoltura-caccia e pesca; 379 unità lavoravano nell’industria; 91 nei trasporti e comunicazioni; 126 svolgevano attività commerciale; 2 erano inseriti nel credito e assicurazione; 22 erano censiti come liberi professionisti e addetti al culto; 24 operavano nella pubblica amministrazione; 3 nell’amministrazione privata; 49 nelle attività di economia domestica; 550 erano gli addetti nell’artigianato; gli inattivi raggiungevano 2258 unità.
A Cariati i dati rilevati nel 1936 facevano emergere, in percentuale rispetto alla popolazione attiva, che: il 58,5% era impiegato nell’agricoltura; il 27,6% erano gli addetti dell’industria e dei trasporti; il 7,4% svolgevano attività commerciale. In conclusione, i cittadini attivi rappresentavano il 43% dei residenti.
La stessa cittadina in quel censimento fu designata come “Regione agraria collinare”, con un’estensione rilevata di 76.320 ettari, e comprendeva anche i territori dei comuni di: Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cropalati, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli e Terravecchia.
In quel vasto comprensorio fu censita una popolazione di 33.898 unità, di cui 28.623 abitavano i centri urbani dei paesi e 5.275 le cosiddette case sparse. Un bacino territoriale di una consistente estensione, situato tra i fiumi Trionto e Nicà che, dalle rive dello Ionio di Cariati, s’innalzava fino alla quota di 875 metri sul livello del mare, corrispondente all’altimetria del paese silano di Longobucco. Un comprensorio di una “Regione agraria collinare” ampia ma scarsamente abitata, infatti, l’ISTAT nei resoconti del censimento indicava in 39 la media della densità di abitanti per Km quadrato in quei dodici comuni.
Relativamente a Terravecchia, paese collinare a 472 metri sul livello del mare, nell’anno 1936, aveva una popolazione legale di 1327 unità, di cui 1269 abitanti nel centro e 58 nelle case di campagne.
Quelli che vi dimoravano abitualmente erano in numero di 1244, suddivisi in 573 maschi e 671 femmine; i terravecchiesi assenti erano in numero 68 in altri centri dell’Italia oltre a 15 dimoranti in Africa orientale.
Cariati e Terravecchia in quei decenni erano lo specchio di tanti altri paesi della Calabria che si contraddistinguevano da una diffusa arretratezza sociale e culturale, con un elevato analfabetismo e caratterizzati dalla mancanza dei servizi essenziali, soprattutto quelli idrici e igienici.
Non esistevano acquedotti né impianti fognari. L’acqua era prelevata alle piccole sorgenti sparse sul territorio comunale, i bisogni corporali erano soddisfatti nei posti più appartati dell’abitato e la notte nei pitali che erano poi riversati sulle strade imbrattando i selciati di escrementi in cui, spesso, razzolavano le galline e gli altri animali domestici.
A Cariati, nel maggio del 1933, era censita una sola sorgente per uso potabile. Era denominata “Frischia” e situata nell’omonima località dell’abitato della marina e aveva una portata di 1,01 litro al secondo. In realtà, quella era un’antica sorgente pubblica, funzionante da tempi immemorabili poiché la stessa era già esistente nel 1867.
Altre piccole sorgive erano sparse sull’intero territorio che, soprattutto nelle campagne, all’occorrenza fornivano l’acqua per cucinare, per lavarsi le mani e il volto versata nei bacili in piccole quantità.
Nella località “Acquagranchi” ve n’erano due, in “Aquaviva” quattro, poi vi era quella di “Barune”, di “Caligiuri”, di “Cisina e “Costa dei Gemeli”. Una fontana era situata a “Frasso”, due alla “Fornara”, un’altra a “Guardaperi”, “Macchia”, “Palumbo” e “Rosello”. Due erano nel “Salice” e altre due nel luogo “Salto”, oltre a quella di “Salto rapano”.
Vi era poi quella di “S. Angelo”, di “Serra Boscosa”, quattro erano a “Serra libera”, ed in ultimo esisteva quella di “Stanò”.
Come si diceva, erano piccoli rivoli, spesso con portate stagionali, le cui acque erano raccolte in piccole cisterne d’accumulo o in abbeveratoi. Quasi quotidianamente bisognava fare la fila per riempire i barili o le lincelle di creta che erano portate sulla testa dalle donne che ritornavano a casa dai lavori nelle campagne. Quei recipienti di terracotta erano tappati con rametti di scino [il lentisco locale] che rilasciava nell’acqua i residui della linfa e conferiva un sapore amarognolo all’acqua emanando anche un delicato odore. Questa pratica era in uso perché l’essenza delle foglie allontanava gli insetti e gli elementi oleosi dei rami che si discioglievano nell’acqua producendo un’azione antiparassitaria e disinfettante.
Al ritorno a casa i varrili [i barili] erano posati nelle varrilare. Erano degli spazi ricavati nelle murature, prevalentemente allocate nei pressi delle porte d’ingresso, su cui erano conficcati una coppia di paletti, disposti su più file, inclinati e con un interasse tale da poter sostenere i barili senza cadere. A livello di pavimento era realizzata una vaschetta in cui si raccoglieva l’acqua che, svuotando i barili, si disperdeva al suolo.
L’attesa alle sorgenti, prima del proprio turno, rappresentava anche un momento di socialità perché le donne, affaccendate nelle cose domestiche durante la giornata, potevano scambiare delle opinioni o animare qualche discussione con le altre compaesane.
Spesso accadeva che alcune di loro, per necessità e bisogno, svolgevano quel servizio come attività economica vendendo la stessa acqua che portavano sul capo alle famiglie più agiate.
Sia i cariatesi sia i terravecchiesi, e così tanti altri paesi del circondario, dovettero attendere gli inizi del 1960 per vedere costruito il primo acquedotto comunale efficiente e che garantiva l’approvvigionamento nel centro abitato per tutto l’anno.
Infatti, solo nei decenni successivi al 1950 iniziava a intravedersi l’idea di un acquedotto consortile che coinvolgesse i comuni da Campana a Cariati.
Perciò, gli enti locali furono sollecitati all’utilizzo dei finanziamenti previsti da una legislazione speciale e dalle sovvenzioni erogate dalla Cassa per il mezzogiorno che i comuni di Campana, Cariati, Scala Coeli e Terravecchia decidevano di destinare alla costruzione di un acquedotto consortile.
L’iter burocratico ebbe inizio il 6 aprile 1943 allorquando, con il decreto prefettizio n. 3242, i consigli comunali dei comuni furono invitati a deliberare lo statuto del consorzio, che era già stato concordato.
Il consiglio comunale di Terravecchia, nella seduta del primo settembre 1950, approvava lo statuto con la delibera n. 10, prendendo atto che dallo stesso consorzio, con la comunicazione del sindaco, datata 12 giugno 1950, si dissociava il comune di Pietrapaola perché intendeva provvedere da sè all’approvvigionamento idrico.
Nello stesso atto si stabiliva che la quantità d’acqua attribuita a Pietrapaola era ripartita, in proporzione al numero degli abitanti, tra Cariati, Scala Coeli e Terravecchia. La sede del consorzio fu fissata nel comune di Campana, perché in quel territorio era costruita la vasca di raccolta delle acque da distribuire.
Gli enti locali interessati, in quella circostanza, costituirono un fondo cassa, per il funzionamento del consorzio, impegnandosi a versare 25 lire per ogni abitante. La durata dell’unione era stabilita in 35 anni. Gli statuti, sottoscritti dai sindaci, furono approvati dalla Prefettura di Cosenza, il 31 marzo 1951.
L’undici luglio di quell’anno, il presidente del consorzio, individuato nella persona del sindaco pro tempore di Campana, con la nota n. 1341, comunicava agli altri sindaci: “…che venerdì prossimo, 13, l’Ingegnere progettista sarà a Campana, per recarsi, il giorno appresso, alle sorgenti che dovranno essere captate. Successivamente, percorrerà tutta la zona, dalla Sila al mare, per lo studio del territorio che dovrà essere attraversato dalla condotta dell’acqua potabile…”.
Per quell’incombenza progettuale, in precedenza, era stato nominato l’Ing. Morrone, al quale fu affidato anche l’incarico di direttore dei lavori.
Il tecnico predispose tutta la documentazione necessaria che fu inviata alle autorità competenti. Il 27 marzo 1952, da Roma, l’On. Vittorio Pugliese comunicava al sindaco di Terravecchia: “Vi informo che la delegazione tecnica della Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il nuovo progetto di massima dell’Acquedotto del Lese, che comprende il Vostro Comune. La spesa prevista è di oltre tre miliardi”.
I lavori di costruzione dell’acquedotto del “Lese” iniziarono coinvolgendo centinaia di lavoratori in diversi cantieri, tant’è che, nel luglio del 1959, a Terravecchia fu realizzato il serbatoio di rifornimento per l’alimentazione del centro urbano e che comprendeva il ripartitore della condotta di Cariati.
Finalmente, nei primi mesi del 1960 Terravecchia e Cariati poterono inaugurare la prima fontana pubblica nel centro abitato.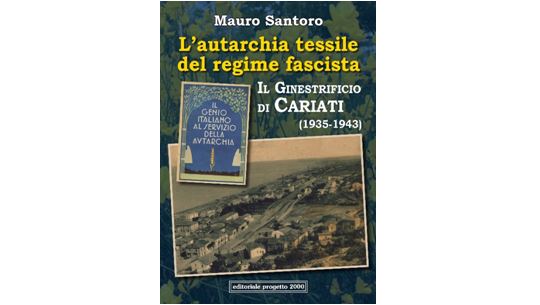
——————
= TESTO TRATTO DA: L’autarchia tessile del regime fascista – Il ginestrificio di Cariati (1935-1943) – Editoriale Progetto 2000 – 2014; ha ricevuto il premio Cassiodoro della Universitas Vivariensis (Cosenza).
Views: 328



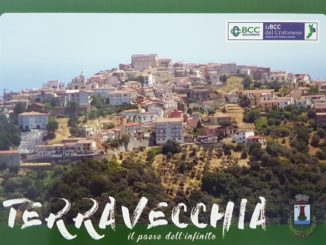


Lascia una risposta
Devi essere connesso per inviare un commento.